di Marco Ghisetti
Un po’ come chi ben comincia è già a metà dell’opera, chi si pone le giuste domande è già a metà della ricerca. Così Amedeo Maddaluno, nel suo breve saggio appena pubblicato, si pone ed sviscera alcuni interrogativi circa l’azione degli Stati Uniti e delle altre grandi potenze in Afghanistan, regione cuore del continente asiatico. La brevità dell’opera non deve essere vista come una pecca, considerata l’effettiva complessità dello scenario afghano. Inoltre, il libro non deve essere visto come il frutto di un tentativo di cavalcare l’onda mediatica del rapido quanto apparentemente improvviso e caotico ritiro statunitense dalla cosiddetta “tomba degli imperi”. Tutt’altro! Come afferma lo stesso autore nelle sue intenzioni: “’sintetizzare’ vuol[e] dire ‘concentrare’ e non ‘semplificare’. Le complessità non vogliamo abolirle, ma anzi metterle in risalto” (p. 11). E infatti, nonostante la brevità, niente in questo saggio è davvero ignorato o lasciato al caso: come sta scritto nell’introduzione, nemmeno “il caos può essere lasciato al caso” (p. 9), poiché, anzi, il caos stesso “potrebbe essere il vero obiettivo” (p. 9).

Afghanistan: il ritorno dei talebani. Che cosa è successo nel cuore dell’Asia
di Amedeo Maddaluno
goWare, 2021
In quest’ottica, un primo pregio dell’ultima fatica di Maddaluno è proprio quello di riuscire a mettere bene in risalto, anche solo per il tramite di alcune brevi e semplici domande e constatazioni, come le principali narrazioni e chiavi di lettura offerte sia dall’accademia che dal giornalismo, siano invero piuttosto insufficienti e contenzione per comprendere ciò che è avvenuto in Afghanistan. Ad esempio: se l’obiettivo dell’invasione statunitense fosse stato di arrestare i mandanti dell’attacco alle Torri Gemelle, perché invadere l’Afghanistan nonostante il governo locale si fosse sin da subito dichiarato disposto a collaborare con le indagini e a consegnare gli eventuali colpevoli alla giustizia? Perché, se l’obiettivo della ventennale occupazione era di sconfiggere insorti e ribelli, gli Stati Uniti si distinsero, non appena fu completata l’occupazione dei principali centri urbani, per una singolare “non-voglia di combattere” (p. 16)? Se l’obiettivo era diffondere liberalismo e democrazia e formare una solida società civile occidentalizzata, perché tutti i progressi sono già crollati come se fossero un castello di carte? E ancora, come si spiega questo ritiro così improvviso e rocambolesco, che lascia sul terreno un’enormità di materiale bellico perfettamente funzionante? Siamo proprio sicuri che gli Stati Uniti abbiano perso? E siamo davvero sicuri che i Talebani abbiano vinto?
E qui arriva il secondo pregio del saggio, ovvero la sua capacità di sviscerare gli interrogativi posti ed unire i puntini delle varie azioni ed omissioni degli Stati Uniti e delle altre grandi potenze senza cadere in inutili pedanterie, luoghi comuni o risposte facili. Ad esempio, se gli Stati Uniti rifiutarono ogni compromesso che non contemplasse l’inserirsi militarmente in Afghanistan, e se si caratterizzarono non cercarono mai davvero di sconfiggere gli afghani che, insorti, resistevano all’occupazione statunitense, oltre all’evidente e prevedibile fallimento di imporre agli afghani uno stile di vita ed una visione del mondo a loro estranea, non si può forse supporre che l’obiettivo degli Stati Uniti non fosse altro che instaurarsi militarmente nel cuore del Medio Oriente, e da lì proseguire all’obiettivo di creare il “Grande Vicino Oriente” (questo sì un obiettivo comune a tutte le famiglie politiche statunitensi), ovvero di frammentare l’Asia centrale e il Vicino Oriente lungo linee etno-culturali più o meno artificiose? Un obiettivo, questo, che era già stato delineato ben prima del crollo delle Torri Gemelle, quando cioè fu chiaro che, agli albori del nuovo millennio, la Cina non era implosa sulla falsa riga dell’Unione Sovietica e la Russia aveva lanciato vari progetti di tessitura eurasiatica, de facto rovinando le speranze delle lobby d’oltreoceano che, con la fine della Guerra Fredda, desideravano l’unificazione del mondo sotto il giogo di Washington. Ma come far ciò, se la Russia e la Cina erano militarmente inattaccabili? Tramite la “geopolitica del caos” (da Maddaluno già ampiamente analizzata in altri lavori), ovvero la promozione della potenza statunitense lungo il continente eurasiatico per il tramite di spallate democratiche, bombardamenti etici e guerre umanitarie. In questo senso, l’occupazione dell’Afghanistan e dell’Iraq erano condizioni imprescindibili per fomentare disordine in tutto il Vicino e Medio Oriente così come nel mondo musulmano al fine di far crollare indirettamente anche Russia e Cina.
E così, sarebbe improprio quello di definire la guerra statunitense in Afghanistan un fallimento, di cui la fuga precipitosa ed apparentemente disordinata e caotica è immagine della sua perdita. L’obiettivo primario della occupazione non era altro che la creazione del “Grande Medio Oriente”, ovvero il frazionamento di tutta una mezzaluna di Stati dalla quale nessuna intesa o collaborazione anti-egemonica sarebbe potuta nascere. Tuttavia, per quanto la creazione del Grande Medio Oriente è effettivamente fallito, per via della collaborazione che si è instaurata tra Cina, Russia e Iran e dell’ostinata resistenza delle popolazioni occupate, sarebbe improprio affermare che gli Stati Uniti in Afghanistan abbiano perso.
Nelle molte analisi che sono state scritte sul ritiro statunitense, spesso si è fatto il parallelo tra la ritirata afghana e quella vietnamita, entrambe guerre che gli Stati Uniti combatterono dispendiosamente per un lungo periodo, salvo poi ritirarsi improvvisamente. Tuttavia, questo parallelo dovrebbe in realtà far riflettere più approfonditamente sulle ragioni e gli obiettivi che gli Statunitensi hanno nutrito in queste due guerre – ed in questo senso il lavoro di Maddaluno si rivela davvero utile. Sarebbe opportuno ricordare, infatti, che poco dopo dieci anni dalla apparente sconfitta vietnamenta, l’Unione Sovietica crollò, lasciando gli Stati Uniti come unica grande superpotenza mondiale. Infatti, l’obiettivo degli Stati Uniti in Vietnam non era assolutamente di prevenire la vittoria del comunismo o di difendere la libertà, come invece la propaganda continua tutt’oggi a sostenere. Altrimenti, ciò non spiegherebbe per quale ragione per tutta la durata della Guerra Fredda gli Stati Uniti non si fecero problemi a sostenere regimi autoritari o ad abbattere governi democraticamente eletti ogni qualvolta i loro interessi lo richiedevano? L’obiettivo della guerra in Vietnam era di evitare che l’economia giapponese si legasse alle potenzialità demografiche ed economiche della Cina e/o dell’Unione Sovietica: eventualità che avrebbe decretato una drastica diminuzione della potenza relativa statunitense, a prescindere dall’appartenenza politica o ideologica del blocco rivale. Gli Stati Uniti combatterono ed occuparono il Vietnam fino a che non si assicurarono che l’economia giapponese (allora il maggior gigante economico ed industriale dell’Asia) sarebbe rimasta saldamente integrata nel blocco occidentale a guida statunitense, senza entrare in sinergia con le potenzialità dell’Asia continentale. Fu solo quando questo obiettivo fu raggiunto, che gli Stati Uniti si ritirarono dal Vietnam.
Le medesime considerazioni valgono per l’Afghanistan e l’improvvisa ritirata: gli Stati Uniti non hanno mai avuto né l’interesse a vincere la guerra, né di occidentalizzare l’Afghanistan, né di catturare i sedicenti responsabili del crollo delle Torri Gemelle. L’obiettivo ultimo era di frammentare l’intera mezzaluna mediorientale e, una volta effettuato, frammentare anche gli ultimi Stati eurasiatici che godevano ancora di una dimensione continentale: Russia e Cina. In alternativa, il Piano B era, interponendosi nel cuore dell’Asia, di promuovere un caos controllato all’interno del mondo musulmano, interdicendo o per lo meno rallentando le varie opere di tessitura eurasiatica che erano state lanciate.
Così come la guerra in Vietnam potrà anche essere stata una sconfitta bellica ma certamente non strategica, sarebbe allo stesso modo improprio sostenere che in Afghanistan gli Stati Uniti abbiano perso. Semplicemente, l’obiettivo degli Stati Uniti non era vincere la guerra. E ora, con la apparentemente caotica quanto improvvisa ritirata, gli Stati Uniti hanno lasciato sul terreno una enorme quantità di materiale bellico perfettamente funzionante e lasciano il governo di un Paese falciato da una guerra ventennale ai Talebani, che ora sono obbligati a stabilizzare un Paese dall’equilibrio precario ed una economia distrutta, mentre invece Cina e Russia devono riuscire a non affondare nelle sabbie mobili afghane. In questo testo Maddaluno riesce egregiamente a sviscerare in pochi paragrafi e considerazioni alcuni dei più importanti e complessi rompicapi del mondo internazionale.
Vi è infine un terzo pregio che caratterizza il saggio di Maddaluno, ovvero l’essere in grado, condensando ma senza semplificare, di fornire anche una panoramica sia sulla validità della geopolitica come disciplina atta all’analisi dei fenomeni mondiali sia sull’influenza che eventuali rappresentazioni del mondo e narrazioni influiscono sull’azione degli attori politici. Scrive Maddaluno: “La geopolitica non è mai deterministica, essa ha sì una base geografica ma per darle uno sbocco politico: è quindi un atto di volontà” (p. 21). La rappresentazione geopolitica che caratterizza, ma che può anche venire promossa o imposta, l’orizzonte di senso entro cui gli eventi mondiali si registrano influiscono enormemente nel modo in cui gli attori politici decidono di muoversi nel dinamico mondo internazionale. Per cui, un’analisi che voglia essere in grado di cogliere le ragioni e gli impulsi che spingono un attore politico a muoversi in un certo modo piuttosto che in un altro, non può prescindere dalla comprensione dell’orizzonte di senso e, quindi, della rappresentazione geografica e politica che egli dà del mondo e dei vari scenari internazionali in cui si muove.
Nel complesso, questi tre pregi permettono al testo di Maddaluno di prestarsi egregiamente sia alla effettiva comprensione di quanto è avvenuto negli ultimi vent’anni in Afghanistan, sia per inquadrare gli orizzonti di senso con cui gli attori politici si sono mossi e continueranno a muoversi in questo – ed altri – scenari del futuro prossimo. Nei fatti, solo su una cosa non siamo pienamente d’accordo con l’Autore: nell’introduzione egli afferma che il saggio è rivolto principalmente ad un pubblico specialistico e che un lettore digiuno di politica internazionale riscontrerebbe difficoltà nella lettura. Dissentiamo. Se infatti la competenza di Maddaluno è in grado di fornire interessanti chiavi di lettura e proficue potenzialità euristiche anche agli analisti più esperti, la scioltezza e la chiarezza con cui l’Autore sviscera i temi trattati e lo scenario afghano nel suo complesso e nella sua complessità – così come l’attenzione che egli pone anche agli aspetti teorici della geopolitica – rendono il testo perfettamente accessibile anche a chi è digiuno di politica internazionale e volesse comprendere, un po’ come la nottola di Minerva che si alza in volo alla fine di un periodo storico, cosa e perché è successo in Afghanistan.












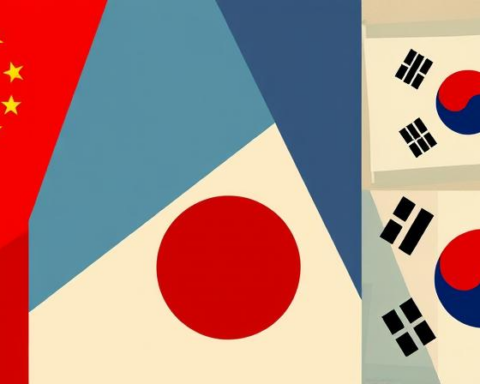




Il CeSE-M sui social