di Matteo Martini
La decisione di Trump di tassare l’intero pianeta con i dazi (compreso Israele) è un avvenimento epocale e rivoluzionario. È vero che ciclicamente gli Stati Uniti hanno dovuto fare ricorso a una dottrina protezionista (sotto Jefferson, sotto Lincoln, persino più di recente sotto FD Roosevelt), ma oggi il tipo di relazioni che gli USA hanno nel sistema del commercio internazionale è completamente diverso, e l’impatto sistemico è incomparabile. Siamo quindi di fronte a un evento molto raro nella storia.
Questa decisione che segna virtualmente la fine del sistema del WTO, e della dottrina del libero scambio, è stata presa per necessità: il tipo di modello economico creato dagli USA aveva deindustrializzato gli USA. Tuttavia è inutile e sbagliato colpevolizzare la “globalizzazione”, quanto la sua gestione finanziarizzata: scelta ad esempio che non è stata seguita dalla Cina e da altri Paesi eurasiatici, che infatti non sono colpiti, se non in minima parte, dai processi socio-economici dissolutivi che ora affronta l’Impero in disfacimento.
Certo il modello economico mondiale è stato finora voluto e imposto dagli Stati Uniti (Washington consensus) e aveva un senso fintanto che il mondo si avviava a diventare un unico sistema unipolare, ma il riaccendersi della competizione geopolitica fra potenze in ascesa, ha messo in luce i limiti di un sistema imperiale che indeboliva il centro a vantaggio delle periferie.
C’è il paradosso che un Paese a socialismo di mercato oggi difende il libero scambio, mentre un Paese liberal-capitalista come gli USA invoca la protezione dello Stato. È la dimostrazione che il secondo ha generato un modello più malato e squilibrato di economia, ma non è questo il punto.
Ora i cambiamenti in corso sono potenzialmente non più gestibili o hanno un tale livello di imprevedibilità che rende assai difficili le previsioni. Il debito pubblico USA grava come un macigno sulla possibilità di riorganizzare la loro economia, e il DOGE è lì per ridurre la spesa pubblica ma non sappiamo se porterà per loro più costi o più benefici.
La necessità di colpire con i dazi tutti i Paesi deriva oggi da un vecchio errore strategico dello stesso Trump, il Trump della prima amministrazione che identificò erroneamente nella causa dei mali dell’America la Cina, da cui la decisione di colpirne l’industria con la guerra delle tariffe. Quella decisione portò alla crescita di altri Paesi concorrenti: gli investimenti cinesi si spostarono in Vietnam e in Messico, ad esempi, che in quegli anni sono cresciute moltissimo, grazie alle produzioni cinesi lì trasferite. Quindi il deficit commerciale americano si è accresciuto con questi Paesi. Hanno così moltiplicato il problema.
Semplicemente, un errore di valutazione, e il sistema dei vasi comunicanti, in un sistema di commerci fortemente integrato hanno fatto il resto. Pensare di recintare un solo paese competitor con i dazi è virtualmente impossibile. Per isolare la Cina devi isolare tutto il mondo: di fatto sarai tu a isolarti. Lo stesso errore lo commise la presidenza Biden con la Russia: pensare di isolare la Russia con le sanzioni ha fatto emergere allo scoperto quanto la Russia fosse integrata a livello internazionale, isolando semmai l’Occidente.
Ma c’è un altro scoglio teorico-pratico che gli USA di Trump dovranno affrontare: ed è il paradosso di Triffin.
Un Paese che vuole rafforzare la propria manifattura e la propria industria e riequilibrare il disavanzo commerciale, deve attuare delle politiche che sono incompatibili con lo status di detentore della moneta di riserva mondiale.
Se uno Stato vuole che la sua moneta sia la valuta di riserva mondiale, deve sostenerla con un disavanzo commerciale. Semplicemente, senza il deficit commerciale USA non ci sarebbe una massa monetaria tale da sostenere il sistema di scambi internazionale.
In assenza di ciò ci sarebbe deflazione e una tale scarsità di valuta da costringere gli altri attori a scambiarsi beni e servizi nelle divise nazionali, o attuare altri sistemi di scambio alternativi.
Per questo il feudalesimo imperiale moderno è più un sistema autosquilibrante destinato a impoverire il centro dell’impero avvantaggiando le periferie. È la riproposizione economica della dialettica servo-padrone di Hegel: il padrone ha bisogno del servo, mentre il servo non ha bisogno del padrone.
Certo, Trump potrebbe voler combattere la sopravvalutazione artificiale del dollaro? Potrebbe fare tutto questo se accettasse di rinunciare al “privilegio del dollaro”. Se accettasse cioè di superare completamente la logica di Bretton-Woods, come è superata quella di Yalta, e di rafforzare la propria industria senza avere un innaturale ruolo di controllo dell’economia mondiale.
Gli Stati Uniti si ridimensionerebbero a grande potenza regionale-globale, in una situazione di parità totale con Cina e Russia (un tripolarismo mondiale) e insieme ad altre potenze medio-grandi. Avrebbe una competizione paritaria a livello strategico, di industria e sul piano militare, senza poteri coercitivi supplementari legati alla moneta. Il che significa perdere più del 50% del proprio potere strategico.
Ma non è questa la strada – peraltro obbligata – che Trump sembra interessato a percorrere: anzi sembra voler colpire con dazi aggiuntivi e sanguinosi qualunque Paese che scegliesse di non commerciare in dollari. Vedremo quanto un’affermazione del genere sarà attuabile, tuttavia è indicativa del fatto che la volontà di restare ancorati al privilegio del dollaro sia ben presente nella leadership americana.
In sostanza, Trump e la sua squadra hanno deciso che devono avere la botte piena e la moglie ubriaca. In realtà sono alle prese con il dilemma di Triffin: quindi contro, possiamo dire, una legge economica.
È una lotta segnata in partenza, e quindi destinata all’insuccesso con grandissima probabilità. Certo non sappiamo i margini e le ricadute di questo insuccesso, un esperimento del genere non è mai stato fatto. Mentre molti imperi “globali” nella storia moderna sono entrati in crisi (quello spagnolo, poi quello olandese, infine quello britannico), una simile crisi “pilotata”, contemporaneamente monetaria e degli scambi (catena di valore globale), probabilmente non si è mai vista. I danni e le conseguenze possono essere molto difficili da prevedere e da controllare. Mentre rispetto al declino statunitense c’è chi in patria lo vede come “troppo poco e troppo tardi”, le conseguenze globali di lungo termine sono incognite. Potrebbe accelerare il processo di dedollarizzazione e creare un clima di insofferenza globale verso gli Stati Uniti, che hanno perso ormai la maschera di egemone benevolo.
Le conseguenze non saranno solo di natura economica, ma strategica e geopolitica.




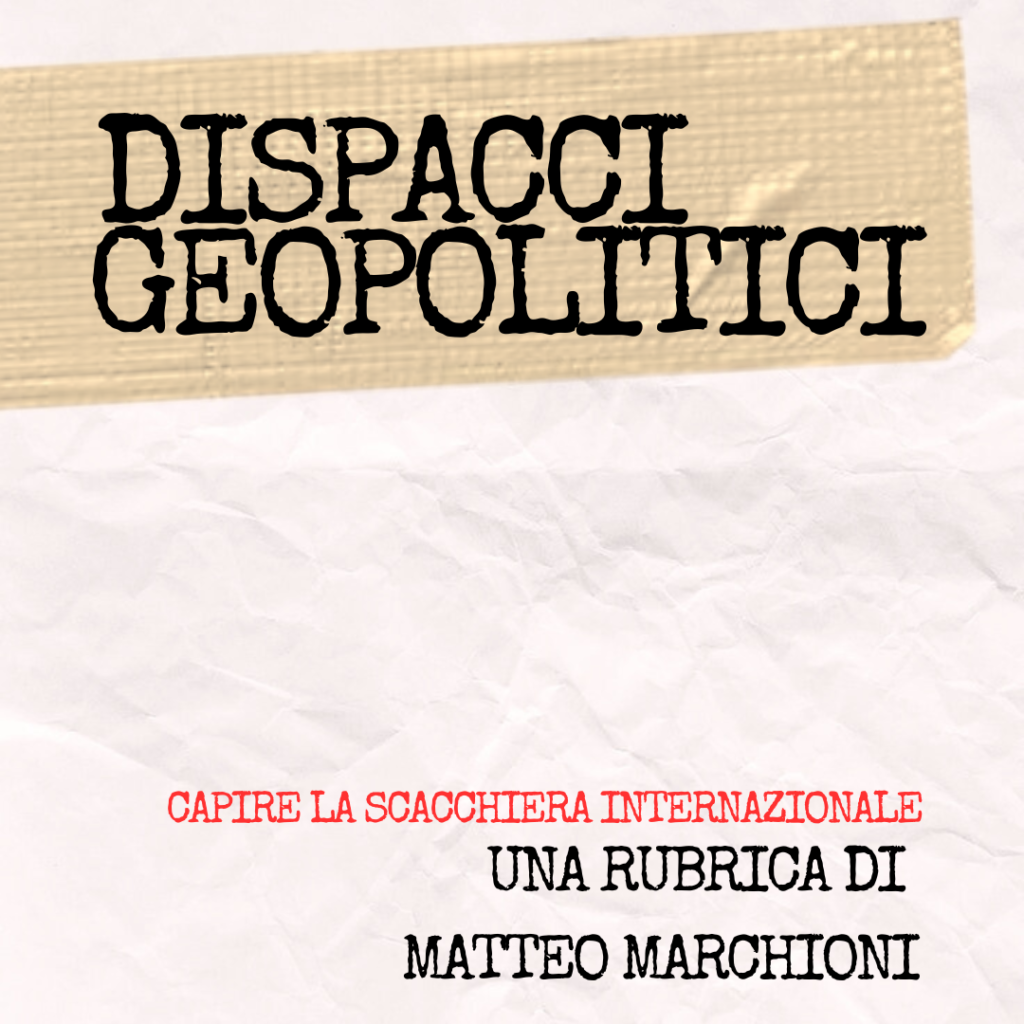
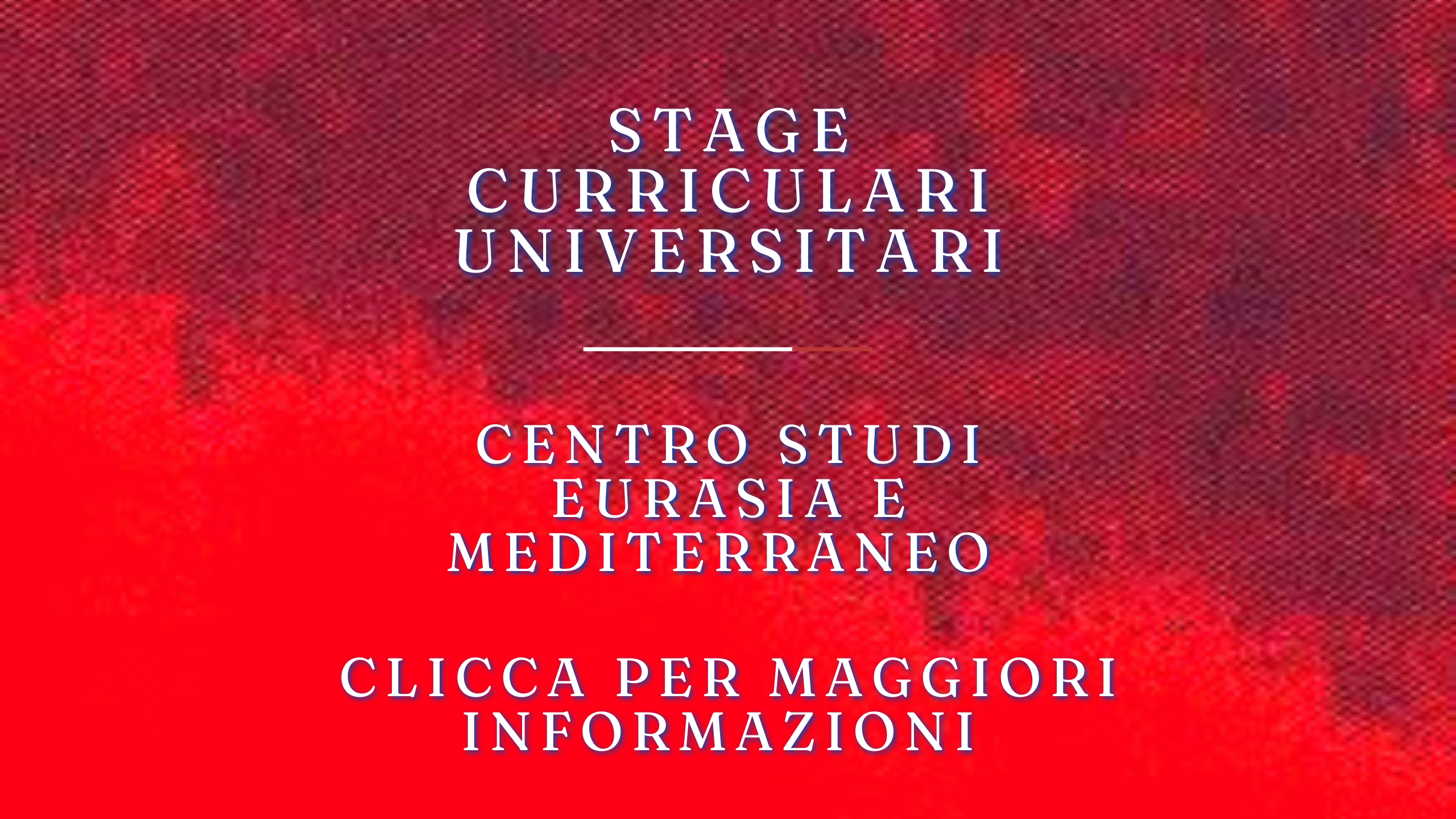

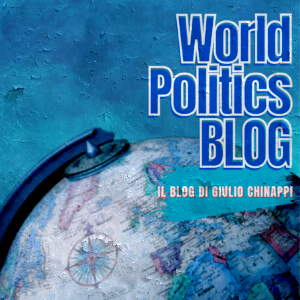
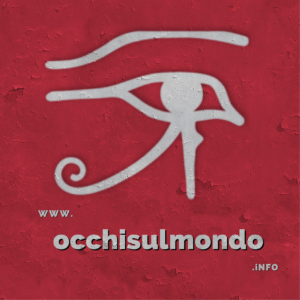









Il CeSE-M sui social