di Andrea Falco Profili
La narrazione convenzionale dell’integrazione europea si è nutrita per decenni dell’immagine dell’asse franco-tedesco come architrave imprescindibile del progetto comunitario. Un’immagine tanto potente quanto idealizzata, che oggi rivela tutta la sua fragilità davanti alla crisi del baricentro continentale. Non assistiamo a un semplice momento di disallineamento transitorio, ma alla manifestazione superficiale di uno strappo profondo che attraversa l’intero edificio delle relazioni bilaterali tra Parigi e Berlino.
L’asse franco-tedesco, eretto a simbolo della riconciliazione post-bellica e tramutato in dispositivo dell’integrazione continentale, oggi è intrappolato nella dialettica tra la sua mitologia e la sua prassi effettiva. La retorica ufficiale continua a celebrarne l’indispensabilità mentre gli ultimi sviluppi ne evidenziano l’esaurimento funzionale. Ciò che si osserva è l’emergere di un effettivo paradosso strutturale: due potenze condannate a cooperare eppure impossibilitate a farlo efficacemente, vincolate da un’interdipendenza che non si traduce più in sintesi politica. Il tandem franco-tedesco sembra vittima del suo stesso successo storico: avendo contribuito a creare un’Europa più complessa e articolata, si scopre oggi inadeguato a governarla.
Le tensioni attuali non sono riducibili alle personalità dei leader o alle contingenze politiche, per quanto queste giochino un ruolo amplificatore. Alla radice troviamo incompatibilità sistemiche che il pragmatismo politico aveva a lungo mascherato ma non risolto. Il centralismo presidenziale francese, con la sua verticalità decisionale concentrata all’Eliseo – esasperata nella “gioviana” visione di Macron – collide strutturalmente con l’architettura policentrica tedesca, dove il federalismo e la cultura della mediazione permanente plasmano un processo decisionale distribuito e incrementale. A questa differenza non trascurabile, poiché riflette concezioni alternative di sovranità ed esercizio del potere politico, si aggiunge il divario tra le culture strategiche, esasperato dalla crisi ucraina: da un lato la Francia post-gollista, con la sua vocazione all’autonomia strategica, la sua proiezione globale e il suo apparato militare-industriale integrato; dall’altro la Germania post-bellica, costruita su un’identità commerciale e su una delega parziale della sicurezza, oggi costretta dalla Zeitenwende (svolta epocale) a una sofferta rinegoziazione del proprio rapporto con la dimensione militare.
Anche i modelli economico-industriali rivelano dissonanze profonde: il capitalismo di Stato francese, con i suoi campioni nazionali e la sua pianificazione strategica, si confronta con il capitalismo renano tedesco, fondato sul Mittelstand (ceto medio) e su una visione ordoliberale che guarda con sospetto all’interventismo statale. La stessa transizione ecologica viene interpretata attraverso queste lenti divergenti: nucleare contro rinnovabili, centralizzazione contro decentralizzazione.
Geometria variabile, sintomo e strategia
La proclamazione di una “coalizione dei volenterosi” rappresenta un fenomeno ambivalente: sintomo della disfunzionalità dell’asse tradizionale – con il fallimento di Macron nel costruire un dialogo con la Russia – e tentativo di costruire strutture alternative di cooperazione europea. Parigi in passato ha ricercato la sua autonomia strategica e militare con iniziative come la EI2, lanciata come formato flessibile di cooperazione militare al di fuori delle strutture UE e NATO. All’inizio del conflitto russo-ucraino la Germania, più legata al quadro atlantico e alle garanzie di sicurezza statunitensi – ha invece avviato la ESSI (European Sky Shield Initiative) senza coordinamento preventivo con la Francia e privilegiando tecnologie americane ed israeliane a quelle europee, suscitando l’ira dell’Eliseo. Ciò rivela un’Europa che procede per cerchi concentrici e coalizioni tematiche più che salda intorno ad un bilateralismo stabile dell’asse tradizionale. Questo scenario solleva un interrogativo cruciale: stiamo assistendo alla nascita di un’Europa più agile e differenziata o alla sua frammentazione definitiva? La moltiplicazione dei formati rappresenta un consolidamento delle “Europe nell’Europa” – come delineato dalle riflessioni di Poggioni e di Amicarella nel corso del dibattito tenutosi a Roma lo scorso 27 marzo – o un pragmatismo necessario? La competizione strategica tra Francia e Germania si manifesta con particolare intensità nel settore della difesa, mentre Berlino ricostruisce il proprio esercito, altera fondamentalmente gli equilibri. Parigi percepisce questa svolta come una potenziale minaccia alla propria tradizionale leadership militare nell’Europa post-brexit, d’altra parte la Germania vede con sospetto il tentativo francese di canalizzare questa nuova disponibilità finanziaria tedesca verso l’industria della difesa francese attraverso progetti comuni.
Macron incarna nei suoi metodi di gestione le contraddizioni dell’approccio francese all’Europa: visionario nei discorsi ma spesso unilaterale nella prassi, capace di articolare una narrazione europea ambiziosa ma frequentemente incapace di costruire le coalizioni necessarie per realizzarla. La tendenza macroniana a lanciare iniziative senza sufficiente coordinamento preventivo, a sorprendere i partner con dichiarazioni dirompenti – si faccia riferimento al caso delle truppe in Ucraina o si abbia memoria della dichiarazione di “morte cerebrale” della NATO – e a oscillare tra multilateralismo dichiarato e verticismo praticato, ha eroso il capitale di fiducia con Berlino. Allo stesso tempo la leadership tedesca appare intrappolata in una crisi esistenziale, divisa tra la nostalgia per l’egemonia discreta dell’era Merkel e la necessità di un nuovo protagonismo geopolitico imposto dalla svolta epocale.
Il nuovo paradigma: Europae interEuropam
L’erosione dell’asse tradizionale come principio organizzatore delle decisioni europee non significa necessariamente la fine del progetto continentale, ma certamente ne impone una riformulazione paradigmatica. L’Europa post-asse potrebbe emergere come una costellazione di epicentri variabili, dove l’integrazione procede a velocità differenziate attraverso coalizioni funzionali e avanguardie tematiche. In questo scenario, il rapporto franco-tedesco – in perenne tensione e minacciato da un qualsiasi risultato elettorale avverso – non scompare ma si relativizza, diventando una relazione importante tra molte altre all’interno di un’architettura continentale più complessa e policentrica. La sfida dei vecchi europeisti sarà evitare che questa differenziazione si trasformi in frammentazione permanente. Reinventare l’asse franco-tedesco sembra oggi una scommessa destinata a fallire, costruire architetture alternative di coordinamento continentale che riflettano nel microcosmo europeo la tendenza multipolare del macrocosmo globale, sembra inevitabile. In ogni caso, sarà necessario superare la retorica convenzionale dell’integrazione europea per affrontare le contraddizioni sistemiche che attraversano il continente.




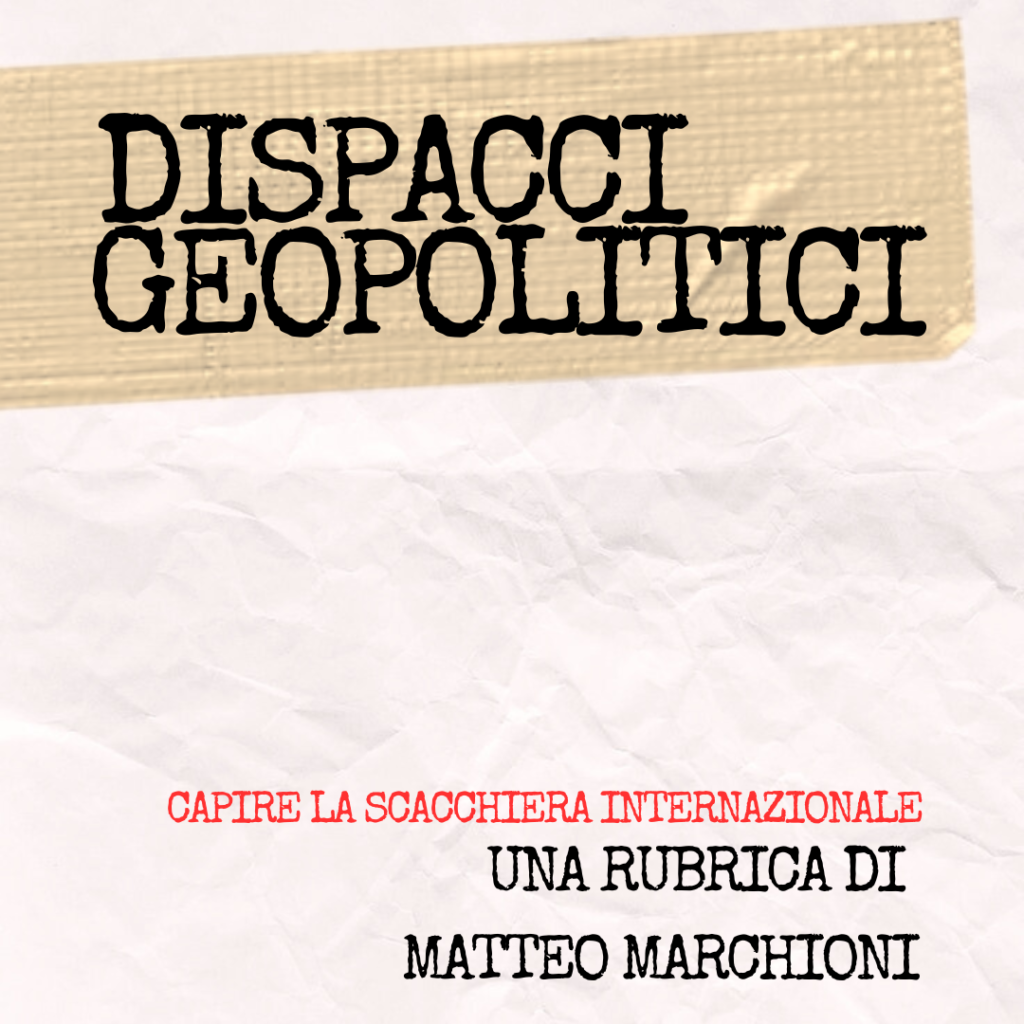
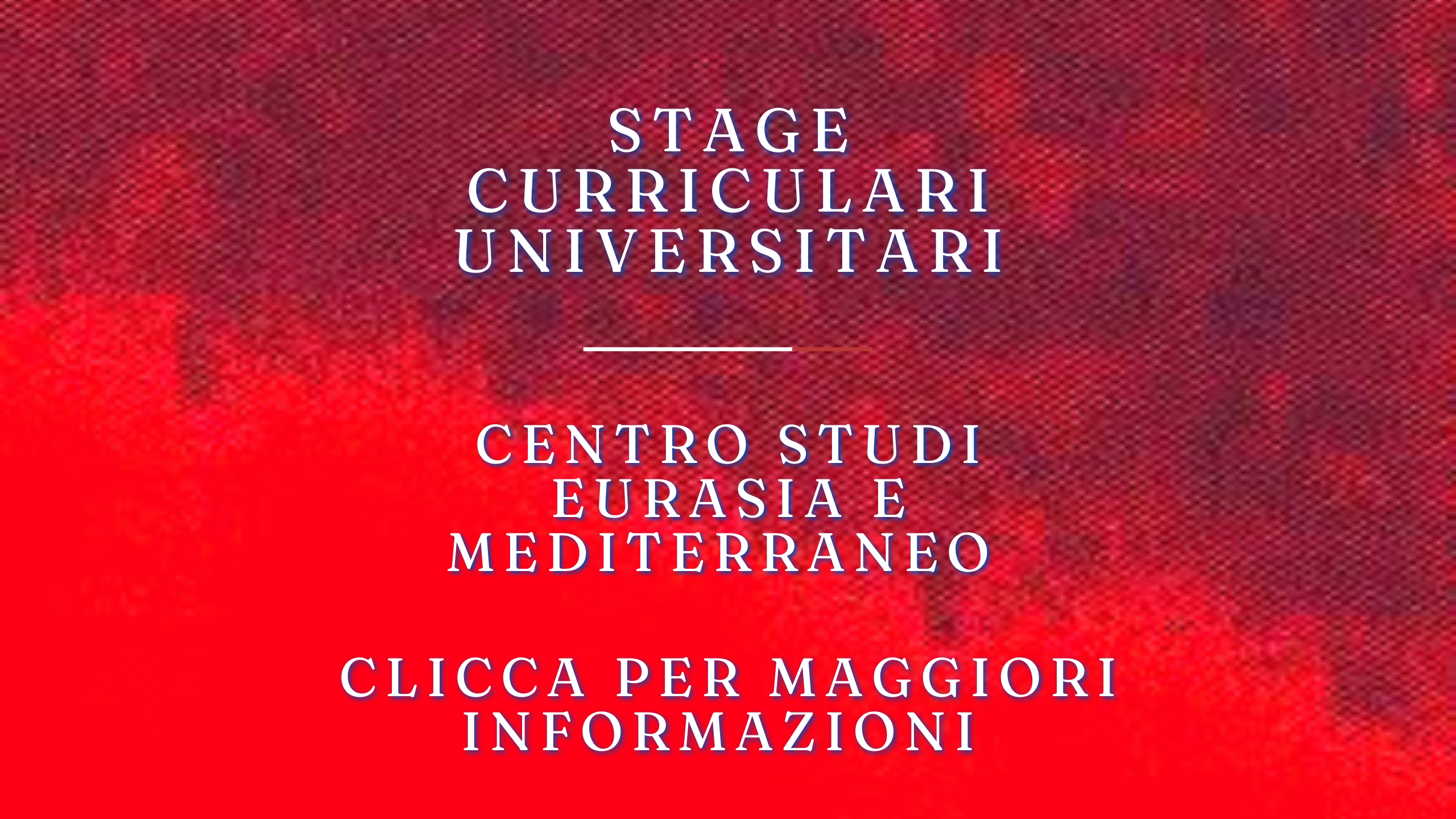

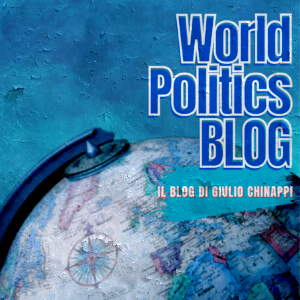
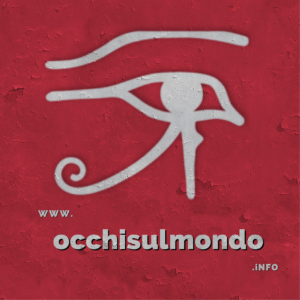









Il CeSE-M sui social