di Stefano Vernole (vicepresidente Centro Studi Eurasia e Mediterraneo)
Un paio di anni fa, i principali think tank statunitensi individuarono nei cosiddetti Swing States il principale campo di battaglia geopolitico del XXI secolo tra i sostenitori del multipolarismo e i fautori dell’unipolarismo a stelle e strisce.
FONTE ARTICOLO: https://strategic-culture.su/news/2025/02/06/con-trump-si-riaccende-la-lotta-globale-per-gli-swing-states/
Un paio di anni fa, i principali think tank statunitensi individuarono nei cosiddetti Swing States (termine ripreso dalla competizione presidenziale USA) il principale campo di battaglia geopolitico del XXI secolo tra i sostenitori del multipolarismo e i fautori dell’unipolarismo a stelle e strisce.
L’esito di questa competizione è destinato a plasmare l’ordine globale per i decenni a venire ma esso non sarà deciso solo dalle azioni di Washington, Pechino o Mosca, dipenderà anche da come un gruppo di Paesi influenti e in ascesa affronterà il mutevole panorama geopolitico.
Questi Paesi sono gli Stati in bilico, nazioni relativamente stabili e prospere che hanno i propri programmi globali indipendenti dalle grandi potenze e la volontà e le capacità di trasformarli in realtà. Sono più esigenti, flessibili, dinamici e strategici di quanto avrebbero potuto essere nel XX secolo, quando dovevano scegliere tra l’allineamento o il non allineamento con un blocco o un altro. E spesso scelgono il multi-vettorialismo, una strategia che li renderà forze critiche, e talvolta imprevedibili, nella prossima fase di globalizzazione multipolare del Pianeta.
I sei Paesi individuati come Swing States sono: Turchia, India, Arabia Saudita, Sudafrica, Indonesia e Brasile. Questi Paesi hanno più potere oggi che mai per diversi motivi: crescono economicamente, traggono vantaggio dalla regionalizzazione e possono sfruttare le tensioni tra Stati Uniti e Cina.
Gli Stati indecisi geopolitici sono pure diventati più sicuri e capaci di perseguire i propri interessi e valori sulla scena globale. Hanno sviluppato autonome capacità di soft e hard power e hanno diversificato le proprie partnership e alleanze, cercando di bilanciare le loro relazioni sia con gli Stati Uniti che con la Cina, così come con altri attori regionali e globali.
La Turchia è il caso più emblematico. Membro della NATO, stringe tuttavia accordi militari ed energetici con la Russia, vuole diventare un hub strategico del gas naturale e assumere il ruolo di mediatore in tutte le principali contese regionali. La sua posizione geografica la rende un partner indispensabile per entrambe le alleanze e le fornisce un margine di manovra estremamente ampio che il Presidente Erdogan sfrutta rapacemente.
L’India è divenuta una delle principali potenze economiche e geopolitiche in Asia e nel mondo. Nuova Delhi ha perseguito una politica estera multi-vettoriale sotto Narendra Modi, ha rafforzato la sua partnership politica con gli Stati Uniti, ha aderito all’alleanza Quad con Giappone, Australia e Stati Uniti ma ha collaborato con la Cina su questioni commerciali e di confine nonostante le storiche tensioni; ha ampliato la sua portata in Africa e America Latina; ha investito in progetti di connettività nei Paesi limitrofi e ha resistito ad ogni pressione occidentale tesa a farle rompere gli importanti legami economici e militari con la Russia.
L’Arabia Saudita del principe Mohammed Bin Salman ha intrapreso un gigantesco programma economico di modernizzazione del Paese per sfuggire alla logica della rendita petrolifera, non ha rinnegato la storica alleanza con gli Stati Uniti d’America ma ha accettato di rendere compatibile il proprio programma Vision 2030 con la Belt and Road Initiative cinese, ha respinto le richieste di Washington di abbassare i prezzi del greggio per mettere in difficoltà la Russia e continua a coordinarsi con Mosca nell’OPEC plus.
Il Sudafrica ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere l’integrazione e la cooperazione regionale in Africa, oltre a rappresentare gli interessi e le prospettive del Continente sulla scena globale. È stato membro fondatore e leader dell’Unione Africana (UA), della Comunità per lo Sviluppo dell’Africa Australe (SADC) e della Nuova Partnership per lo Sviluppo dell’Africa (NEPAD). Ha inoltre partecipato a sforzi di mantenimento della pace e mediazione in Paesi come Sudan, Somalia e Repubblica Democratica del Congo. Il Sudafrica ha sfruttato la sua posizione di economia più industrializzata e diversificata in Africa per attrarre investimenti e scambi esteri, in particolare da Cina, India e UE, si è addirittura fatto promotore della denuncia di Israele alla Corte Internazionale di Giustizia per genocidio a Gaza alla quale si è poi associata l’Irlanda.
L’Indonesia è emersa come un attore chiave nel Sud-est asiatico e nella più ampia regione indo-pacifica, nonché un ponte tra l’Asia e il mondo islamico. Giacarta è stata una forza trainante dietro l’Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN), la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) e la Partnership Strategica Asia-Africa (AASP). Ha inoltre avviato un dialogo e una cooperazione con altri attori regionali come Cina, Giappone, India, Australia e Stati Uniti su questioni quali sicurezza marittima, antiterrorismo, cambiamenti climatici e risposta alla pandemia. L’Indonesia ha sfruttato la sua posizione di maggiore economia e Paese a maggioranza musulmana più popoloso del Sud-est asiatico per promuovere la sua visione di una regione democratica, tollerante e prospera, decidendo all’inizio del 2025 di unirsi ai BRICS.
Il Brasile è stato un leader in America Latina e nei Caraibi, nonché una voce per il sud del mondo su questioni quali commercio, ambiente e diritti umani. È stato un membro fondatore e una forza trainante dietro organizzazioni regionali come Mercosur, Unasur e Celac. Brasilia ha avviato un dialogo concreto con altri attori regionali come Stati Uniti, Cina, India e UE su questioni quali sicurezza energetica, sviluppo delle infrastrutture e inclusione sociale. Il Brasile ha sfruttato la sua posizione di maggiore economia e Paese più popoloso dell’America Latina per promuovere i suoi interessi e valori nella regione e oltre; ha cercato di mediare nel conflitto in Ucraina, proponendo insieme alla Cina un piano di pace alle Nazioni Unite che ha raccolto il consenso di 110 Paesi.
Finchè gli Stati Uniti rimarranno una grande potenza finanziaria e militare, questi Paesi modelleranno le regole e le norme del sistema emergente in base alle proprie preferenze e principi, non accetteranno una scelta binaria tra Stati Uniti e Cina ma cercheranno di preservare la propria autonomia strategica e flessibilità, richiedendo più voce e rappresentanza nelle istituzioni e nei forum globali tradizionali e approfondendo la loro cooperazione con i formati geopolitici emergenti come i BRICS, l’ASEAN e l’OCS.
La chiave per portarli da una parte e dall’altra sarà rispettare quei valori e interessi consolidati ai quali nessuno degli Swing States intende rinunciare. Ciò sancisce l’attuale successo dei BRICS plus, gruppo al quale appartengono ufficialmente quattro degli Stati contesi (Brasile India, Indonesia e Sudafrica) e che suscita comunque l’interesse degli altri due (la Turchia ha ricevuto l’invito a diventarne un membro partner, mentre l’Arabia Saudita sta temporeggiando sull’ingresso ufficiale ma sfrutta la cooperazione economica con i BRICS per rafforzare il proprio ruolo strategico regionale e globale), dati i principi di appartenenza fondamentali per farne parte: la non ingerenza negli affari interni degli Stati sovrani, il rispetto delle differenze politiche, culturali e religiose di ciascun Paese e l’accettazione di modelli economici e tempi di crescita diversi.
L’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca e la sua insistenza sulla preminenza degli interessi nazionali, tuttavia, va letta proprio nell’intenzione di Washington di sfidare i BRICS sul piano dell’attrattività; la rinuncia/ostilità all’ideologia green o a quella woke (entrambe indigeste ai Paesi del Sud globale) fanno parte del corteggiamento che il nuovo Presidente USA sta conducendo nei confronti degli Swing States.





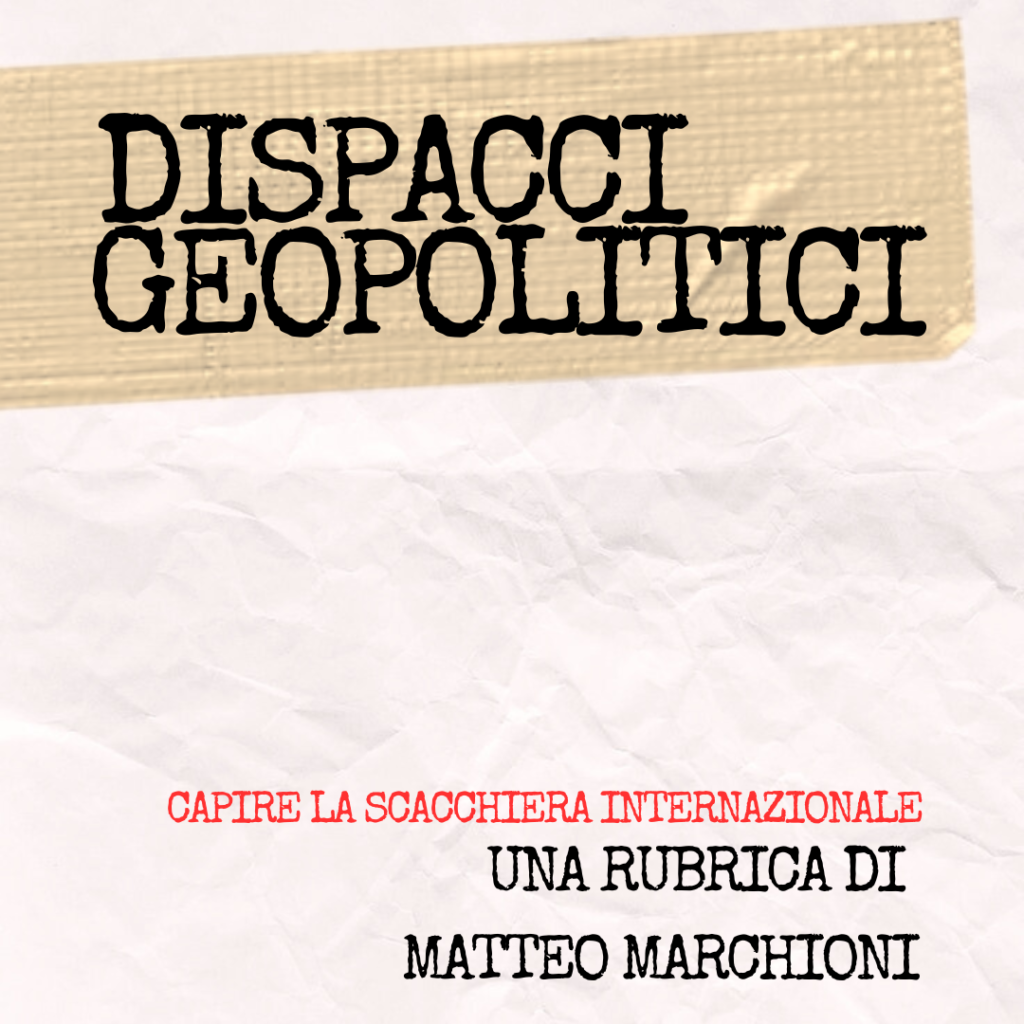
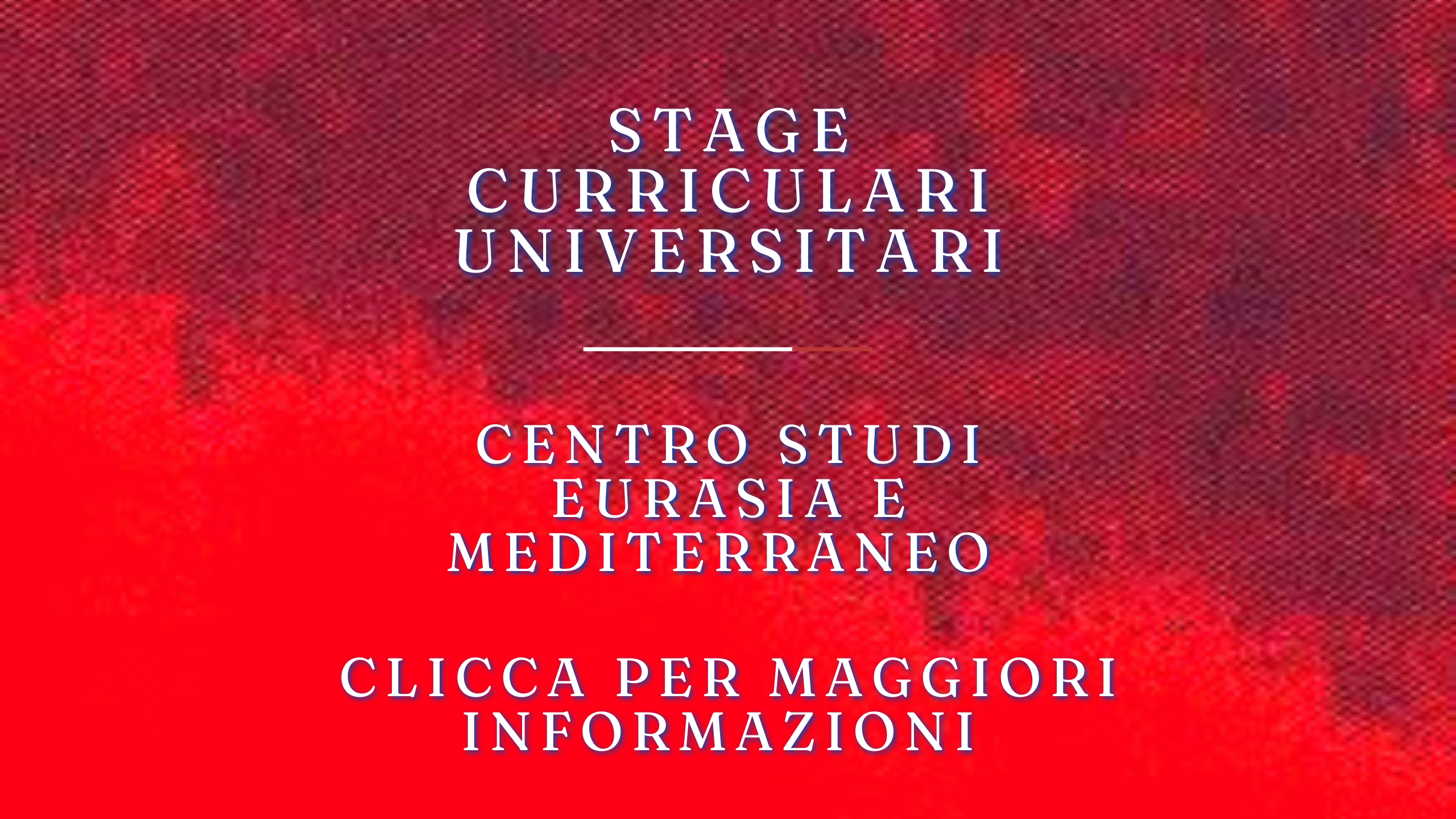

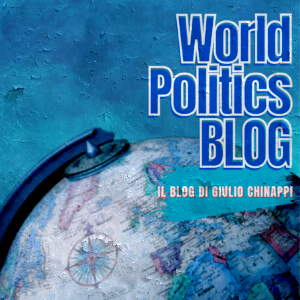
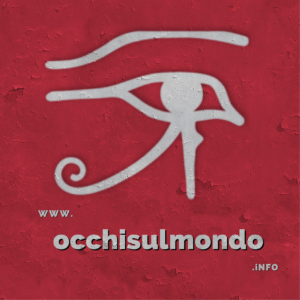



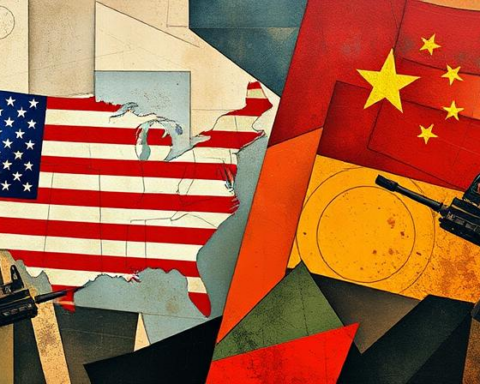

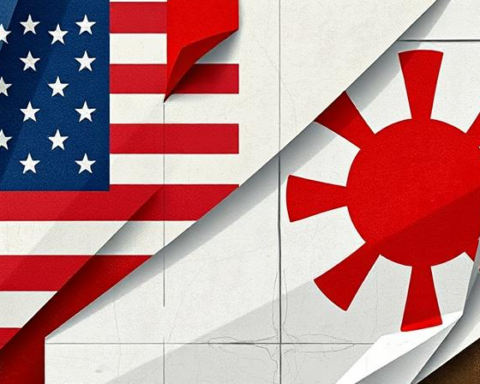



Il CeSE-M sui social