a cura di Stefano Vernole
Intervista del Centro Studi Eurasia e Mediterrano al Gen. Marco Bertolini
- Buongiorno Generale. La settimana si è aperta con le reazioni del Governo italiano alle dichiarazioni di Jens Stoltenberg; il Segretario generale della NATO ha invitato gli alleati che forniscono armi all’Ucraina a “valutare” di porre fine al divieto di utilizzarle per colpire obiettivi militari in Russia, perché Kiev “ha il diritto di difendersi e questo include anche colpire obiettivi in territorio russo”. Fermo restando che, in realtà, l’Ucraina già da due anni colpisce obiettivi nel territorio della Federazione Russa (Belgorod in particolare) e non solo nella Crimea contesa, ritiene che il Governo italiano saprà resistere anche dopo le elezioni europee all’effetto “trascinamento” dovuto alle parole di Stoltenberg e di altri leader europei (Macron in particolare)? Non le pare che la retorica atlantista, giorno dopo giorno, cerchi l’escalation e che i precedenti comportamenti del nostro Paese alle pressioni statunitensi non rassicurino in pieno sulla possibilità di rimanere fuori da un allargamento del conflitto?
“Innanzitutto credo di dover ammettere che Stoltenberg ha messo a nudo, certamente senza volerlo, l’ipocrisia dell’Occidente nel suo complesso. L’Occidente, inteso come quel conglomerato che fa capo all’anglosfera in generale e alla Nato e all’UE in particolare, è da due anni in guerra con la Russia. Lo è per i toni offensivi (macellaio, criminale, dittatore, ecc.) utilizzati per definire quello che era e continua ad essere il Presidente eletto e riconosciuto di un Paese col quale abbiamo ancora rapporti diplomatici, per le dimostrazioni di odio “razziale” evidenziato contro tutto quello che è russo (dalla cultura allo sport arrivando ad escludere gli atleti paraolimpici di quel paese dalle competizioni internazionali), nonché ovviamente per il regime di sanzioni che oltre a colpire soprattutto le nostre economie contraddice decenni di rapporti commerciali tra Europa occidentale e Europa slava che hanno portato benessere e ricchezza ad entrambe. Nonché sicurezza.
Ma in tutto questo lungo lasso di tempo, continuava una ostilità di fondo soprattutto da parte di quell’estremo occidente che mal digeriva una saldatura tra Europa e Asia per il tramite della Russia che minacciasse di creare un centro di potere enorme nel cosiddetto Heartland di Mackinder, l’inventore della Geopolitica. E questo, a detrimento delle potenze insulari, navali e anglosassoni che da sempre vedono l’Europa come un’entità in qualche modo estranea, se non ostile. Comunque, da controllare.
Negli stessi anni nei quali Vladimir Putin veniva ricevuto nelle nostre cancellerie con tutti gli onori, infatti, non mancavano azioni dirette a intaccare quello che rimaneva dell’area di influenza russa travolta dal crollo sovietico. A pochi anni dalla caduta del Muro di Berlino se ne costruiva uno più piccolo nei Balcani per isolare la piccola Serbia e ghettizzare l’ancor più piccola Republika Srpska di Bosnia, mentre quasi tutti i paesi una volta alleati nel Patto di Varsavia passavano alla Nato, assieme addirittura a parti dell’ex URSS stessa (i Paesi baltici). Con le primavere arabe, iniziate guarda caso sempre dal trio USA, UK e Francia con l’attacco alla Libia e la distruzione della Siria, storica alleata di Mosca, il quadro era quindi pronto per ulteriori sviluppi, ora purtroppo sotto i nostri occhi.
Tralasciando questa digressione storica e tornando al punto, l’ipocrisia dell’Occidente ha toccato l’apice con la fornitura di armi sofisticatissime all’Ucraina, con la clausola pilatesca di vietarne – almeno ufficialmente – l’uso contro il territorio russo. Una clausola assurda e probabilmente impossibile da rispettare, da parte di chi con quelle armi combatte un nemico più forte. E da chi ora percepisce chiaramente che la propria sopravvivenza politica se non addirittura fisica dipende dagli esiti di una guerra che pare ormai persa sul campo; a meno che non si rimetta tutto in gioco allargandone il perimetro e coinvolgendo Nato ed Unione Europea.
In questo “vorrei ma non posso”, insomma, risiede tutta la doppiezza occidentale messa a nudo da Stoltenberg con un “il re è nudo!” che imbarazza tutti. E l’imbarazzo è anche motivato dal fatto che, a differenza di Macron che è il Presidente eletto della Francia e che, come tale, è nel suo pieno diritto di fare e dire quello che ritiene necessario nell’interesse del proprio Paese, Stoltenberg è soltanto un alto funzionario nominato, i cui poteri si limitano a riportare e coordinare le decisioni assunte all’unanimità dai Paesi della Nato, alcuni dei quali come noto non vedono di buon occhio la ricerca di altre grane.
Resta il fatto che non credo parli per dar aria ai denti e certamente partecipa, senza averne titolo, ad una escalation dei toni iniziata due anni fa almeno, per preparare le opinioni pubbliche e portare alle estreme conseguenze una guerra che fino ad ora vede la Russia in notevole vantaggio, a livello tattico-operativo, con grande scorno di chi ne prevedeva la sconfitta definitiva e l’esclusione da Europa e Mar Mediterraneo.
Insomma, siamo arrivati alle prevedibili conseguenze di una sciagurata condotta con la quale tutto l’Occidente si è piegato alle decisioni belliciste di Londra e Washington nell’illusione che sussistesse una differenza di potenziale tecnologico, sociale, morale e motivazionale sufficiente per avere la meglio su Mosca.
Detto questo, ci sono da registrare con sollievo le prese di distanza di molti governi, tra i quali il nostro, dalle pretese di Stoltenberg e di Macron; ma effettivamente ho qualche dubbio che tale atteggiamento prudenziale reggerebbe di fronte ad un grande incidente nucleare ad Energodar, ad esempio, da due anni esposta al fuoco dell’artiglieria ucraina mentre tutti sembrano essersene dimenticati, o a un casus belli di forte impatto mediatico con conseguente chiamata alle armi in difesa della “democrazia” ucraina”.
- Dal 17 aprile, l’Ucraina ha utilizzato almeno 50 ATCMS per attaccare vari bersagli. Alcuni di questi attacchi hanno avuto successo e hanno colpito installazioni importanti: almeno due S-400, un deposito di munizioni, e almeno tre aerei in un attacco all’aeroporto di Belbek il 16 maggio. Uno dei due radar di Armavir, nella Russia meridionale, è stato colpito e, a giudicare dalle foto, danneggiato. I due sistemi radar di Armavir, che operano su frequenze UHF, coprono l’Iran, il Medio Oriente e la parte più meridionale dell’Ucraina. Soprattutto, sono uno dei tasselli della rete di early warning russa per la propria difesa da attacchi missilistici e nucleari ICBM; possono anche identificare aerei e missili di altro tipo, ma il loro ruolo principale è quello. In pratica, un radar che serve alla Russia per identificare missili nucleari diretti verso il suo territorio è stato colpito. Se un radar di quel tipo viene danneggiato non solo le capacità di difesa contro un attacco nucleare vengono limitate, ma aumenta a dismisura il rischio di identificare come una minaccia qualcosa che non lo è e fare scattare le contromisure del caso anche in assenza di una minaccia. Insomma, lei ritiene che il rischio di una risposta russa, anche di tipo nucleare, sia ancora concreto?
“Questo è uno dei rischi ai quali facevo riferimento. I sistemi Early Warning di Stati Uniti e Russia soprattutto, ma questo vale anche per la Cina, sono parte integrante del deterrente nucleare nel suo complesso, assieme alle armi e ai vettori per lanciarle sugli obiettivi. E’ grazie ad essi che le potenze nucleari sono in grado di individuare minacce al proprio territorio molto prima che si palesino all’orizzonte. Ma è anche grazie alla consapevolezza della loro esistenza che il potenziale nemico sa che i suoi attacchi verrebbero individuati con grande anticipo, dando il via alla rappresaglia.
Per venire al caso particolare da lei citato, l’eventuale inefficienza dell’Early warning di Armavir, che aprirebbe una falla nell’angolo sud occidentale russo, potrebbe innescare falsi allarmi o, addirittura, spingere la Russia a un attacco preventivo per evitare il primo colpo avversario. Insomma, se con tale “colpo” Zelensky avesse ottenuto la messa fuori uso del radar, avrebbe inferto un grave danno non solo alle difese della Russia, ma anche a quelle degli Stati Uniti ora esposti a una reazione nei confronti del suo deterrente strategico e non semplicemente del suo “strumento” tattico ucraino. A meno che gli Usa non siano come possibile dietro all’attacco, il che farebbe presumere imminente lo sfruttamento dei suoi risultati, con le conseguenze che possiamo immaginare.
Ma Zelensky ora non sta andando troppo per il sottile in quanto sta combattendo per la propria sopravvivenza. Una sopravvivenza messa a rischio dai continui rovesci sul campo, dalla resistenza sempre maggiore a una mobilitazione che sfianca quello che resta della società ucraina, da accuse di illegittimità politica derivanti dalla scadenza del suo mandato elettorale, dalla presenza di altri personaggi come Arestovich e Zaluzny che ancorchè allontanati dall’Ucraina non mancano di esprimere un maggiore carisma, dalla stanchezza delle opinioni pubbliche occidentali sempre più restie a provare come ci si senta a “morire per Kiev”.
D’altro canto, può contare sul terrore dell’Occidente per una possibile vittoria russa che metterebbe a rischio la sua credibilità complessiva, per quello che ha investito in questa guerra per procura da un punto di vista retorico, politico, finanziario, energetico e militare, esprimendo in quest’ultimo campo il meglio dei suoi per ora insufficienti strumenti tattici. A questo occidente che ha già dovuto fare molti passi indietro in Africa dà voce la Francia con un interventismo pericoloso che per ora non sembra attrarre altri se non i piccoli e arrabbiatissimi Stati baltici, desiderosi di menare le mani, stando però ben attaccati alle gonne di mamma UK.”
- In Europa sembra di trovarsi di fronte ad una “tempesta perfetta”. L’Ucraina sta generando un effetto domino estremamente pericoloso e diverse crisi regionali vengono riattivate: Balcani (Republika Srpska e Kosovo), Transnistria e Gagauzia (Moldavia e Romania), Kaliningrad e Corridoio di Suwalki (Germania, Polonia e Bielorussia), Caucaso (Armenia e Azerbaigian), tensioni nel Baltico per la delimitazione dei confini (Estonia, Lituania e Finlandia) e la rivalità russo-inglese per il controllo del Mar Nero. Il presidente ungherese Viktor Orban ha denunciato non solo l’aggressività dell’opinione pubblica europea ma anche lo svolgimento di una riunione a Bruxelles con l’obiettivo di coinvolgere direttamente la NATO nel conflitto ucraino ma, inevitabilmente, anche negli altri teatri di crisi. Come valuta la proposta di un esercito europeo integrato con la NATO (ventilato recentemente da Von Der Leyen e altri)? Oppure sarebbe preferibile un riposizionamento sul proprio interesse nazionale come suggerito proprio da Orban?
“Le preoccupazioni derivanti dalla guerra in Ucraina ci fanno spesso dimenticare il contesto generale, ancor più preoccupante. Che la Russia sia circondata è un fatto incontestabile non solo per il passaggio di molti Paesi dal Patto di Varsavia alla Nato o per l’influenza statunitense nelle ex repubbliche meridionali sovietiche, ma anche per il proporsi di situazioni di crisi che si trovano a un passo dall’esplodere proprio ai margini del Paese. E’ il caso del Mar Baltico, improvvisamente diventato un lago “Nato” con il passaggio di Svezia e Finlandia all’Alleanza atlantica dopo una prolungata neutralità, anche se base di una delle cinque flotte russe, a Kaliningrad. Il fatto che l’Ammiraglio Stavridis, ex SACEUR ed ora altissimo dirigente della Fondazione Rockefeller abbia parlato della necessità di neutralizzare l’enclave russa in caso di crisi fa chiaramente intravvedere la possibilità non remota di un caso ucraino anche a quelle latitudini, per la soddisfazione delle repubbliche baltiche e della Polonia. Analoghe ragioni di crisi sussistono in Romania, con la prevista costruzione a Mihail Kogqlniceanu, vicino a Costanza sulla costa del Mar Nero, della più grande base militare NATO in Europa. Intanto, le manovre moldave per ricondurre alla sovranità di Chisinau la Transnistria “russa” non può che essere percepita come una minaccia da Mosca che da decenni impiega nella stretta striscia di territorio un suo limitato contingente di pace.
Nei Balcani, intanto, è in atto da tempo una notevole pressione contro la realtà serba. L’istituzione per iniziativa dell’Assemblea Generale dell’ONU di una giornata della memoria per il “genocidio” di Srebrenica ha fortemente colpito la popolazione serba di Bosnia che, a sentire il presidente della Republika Srbska, potrebbe ora decidere per la propria separazione dalla BiH. Insomma, una specie di “25 aprile” balcanico, che dimostra la vera funzione di certe “giornate della memoria”, non destinate a superare le brutture di ieri, ma semplicemente a congelarle in funzione di una loro utilità in futuro; o per impedire a paesi potenzialmente importanti, è il caso dell’Italia, di presentarsi nell’agone internazionale con una sola voce.
Nel Caucaso, altra area strategica nella quale si incrociano e si scontrano gli interessi russi e statunitensi (e turchi), la situazione non è migliore, con la Georgia aspirante Nato e UE, interessata da manifestazioni che potrebbero portare a una Euromaidan locale col pretesto di una legge che vorrebbe semplicemente assicurare trasparenza ai finanziamenti delle ONG. Fortunatamente, per ora la reazione del governo tiene testa alle facili indignazioni dell’Occidente che vorrebbe dettare le scelte politiche locali, ma l’area è troppo importante per rinunciare all’apertura di un nuovo fronte che impegni Mosca. E, ovviamente, non si può dimenticare il conflitto azero-armeno con Usa, Russia e Turchia che si contendono il controllo dell’area, fondamentale per la realizzazione del corridoio che da San Pietroburgo dovrebbe portare all’Iran e da questo all’India. Quanto all’Iran, il suo contrasto con Israele getta quantomeno un’ombra di dubbio sulla casualità dell’incidente che ha portato alla morte del Presidente Raisi e del suo Ministro degli Esteri, rendendo ancor più instabile un’area di congiunzione tra crisi Ucraina e crisi mediorientale, capace di attirare tutti nel suo vortice.
Venendo alla domanda specifica, di fronte a questa proliferazione non casuale di crisi, la tentazione di dare vita a un “Esercito europeo” si fa ancora sentire. Credo che si tratti però di un falso problema tendente a far dimenticare la natura principale delle Forze Armate come presidio di sovranità nazionale. Insomma, la creazione di uno strumento militare “europeo” sull’onda dei timori della crisi ucraina si tradurrebbe in una semplice abdicazione a quello che rimane delle singole sovranità nazionali, per affidare le proprie forze a un comando che, nel caso specifico, sarebbe sotto il controllo di altri; in particolare di Francia, Germania, Polonia o UK (anche se estranea all’UE), tutti Paesi concentrati sui “propri” interessi nazionali più che su quelli evanescenti e virtuali dell’Unione o dell’Alleanza”.
- Se in Europa la situazione è critica, nel resto del mondo non sembra andare molto meglio. In Africa assistiamo ad un confronto a tutto campo tra potenze occidentali e nazioni BRICS, con i Turchi quale terzo incomodo, per il controllo delle rispettive sfere d’influenza; in Medio Oriente fungiamo da spettatori attivi al massacro palestinese (tramite fornitura di armi ad Israele) e all’intensificarsi dei rancori del mondo islamico contro l’Occidente; in Asia la crisi di Taiwan sta salendo pericolosamente di livello. Sembra evidente che senza un ritorno alla diplomazia internazionale, il futuro del mondo sarà sempre più nebuloso e pericoloso. Cosa possiamo aspettarci da questo punto di vista nei prossimi mesi/anni? Esiste un potenziale diplomatico per almeno limitare l’attuale e futura conflittualità?
“Siamo in una fase di drammatica trasformazione del sedicente ordine mondiale in qualcosa di diverso ancora difficile da prevedere. Certamente la realtà dei BRICS appare minacciosa nei confronti del tradizionale predominio anglo-occidentale ma, d’altro canto, non ci sono dubbi che sotto il profilo strategico i giochi non sono ancora fatti. Si sta consolidando un forte legame tra Russia e Cina, anche sotto il profilo militare, ma è anche vero che le aree di frizione o di scontro tra occidente e oriente lungo la saldatura euroasiatica pongono alla Russia grandi problemi con i quali fare i conti. A questa situazione si aggiunge l’insolubile problema mediorientale, nel quale agisce con spregiudicatezza estrema Israele, una specie di innesto occidentale in oriente, senza tema di dover rispondere a nessuno delle proprie azioni, anche delle più crudeli nei confronti della popolazione palestinese. E il fantasma di uno scontro regionale che coinvolga l’enorme Iran, da anni obiettivo di attacchi in Siria, non permette di coltivare troppe illusioni su un futuro tranquillo.
Insomma, non sembra un’era di pace quella che si prospetta, e questo sgombra il campo da un’altra ipocrisia di fondo dell’occidente, costretto ora a rinunciare dall’irrompere della realtà all’illusione che la guerra sia stata cancellata dalla storia con l’affermazione delle democrazie e con la sconfitta degli autoritarismi europei ottant’anni fa. Questa realtà contraddice il sogno onirico di Francis Fukuyama per il quale non ci dovrebbe essere più bisogno della storia, che invece fa ancora bella mostra di sé nel nostro virtuoso presente. Virtuoso, inclusivo, accogliente, solidale ed ecosostenibile.
Ci sarebbe effettivamente bisogno di una diplomazia in grado di ridurre le tensioni, ma ancor prima ci sarebbe bisogno di una politica che effettivamente prediliga – e non solo a parole – il dialogo rispetto allo scontro. E’ la politica che muove la diplomazia, infatti, e se la politica vuole la guerra la diplomazia non può che fare un passo indietro.
Può sembrare strano, infatti, ma per molti la guerra continua a non essere il male assoluto, ma un modo accettabile per difendere quelli che si considerano interessi vitali del proprio Paese, giusto o sbagliato che sia. Per questo, viene condotta dai soldati e non dai poliziotti anche se nella nostra ipocrita ricerca di eufemismi che mettano d’accordo infatuazioni costituzionali e realtà politicamente scorrette siamo arrivati a inventare la categoria delle operazioni di polizia internazionale, sorelle gemelle dell’ossimoro delle operazioni di pace, a suon di cannonate s’intende. Credo personalmente che il riferimento a “interessi vitali” possa essere comprensibile per tutti, come quello al “proprio Paese”. Ma è comunque necessario specificare che non sono vitali i valori o principi che spesso si tirano in ballo (es. la “democrazia”) soprattutto quando sono utilizzati per stroncare sul nascere le velleità di difesa altrui. Purtroppo, lo si fa da decenni e se fossimo stati attenti a quello che accadeva nel mondo esterno rispetto alla nostra bolla euroatlantica, ce ne saremmo dovuti accorgere molto prima di oggi. Molto prima di andare a sbattere”.
- Marco Bertolini, generale di corpo d’armata (r) dell’Esercito Italiano, è nato a Parma il 21 giugno 1953. Ufficiale paracadutista, ha concluso il servizio attivo il 1 luglio 2016 alla guida del Comando Operativo di Vertice Interforze (Coi) della Difesa da cui dipendono tutte le operazioni delle Forze Armate in Italia e all’estero.
- Stefano Vernole, giornalista pubblicista e analista geopolitico, è Vicepresidente del Centro Studi Eurasia Mediterraneo.




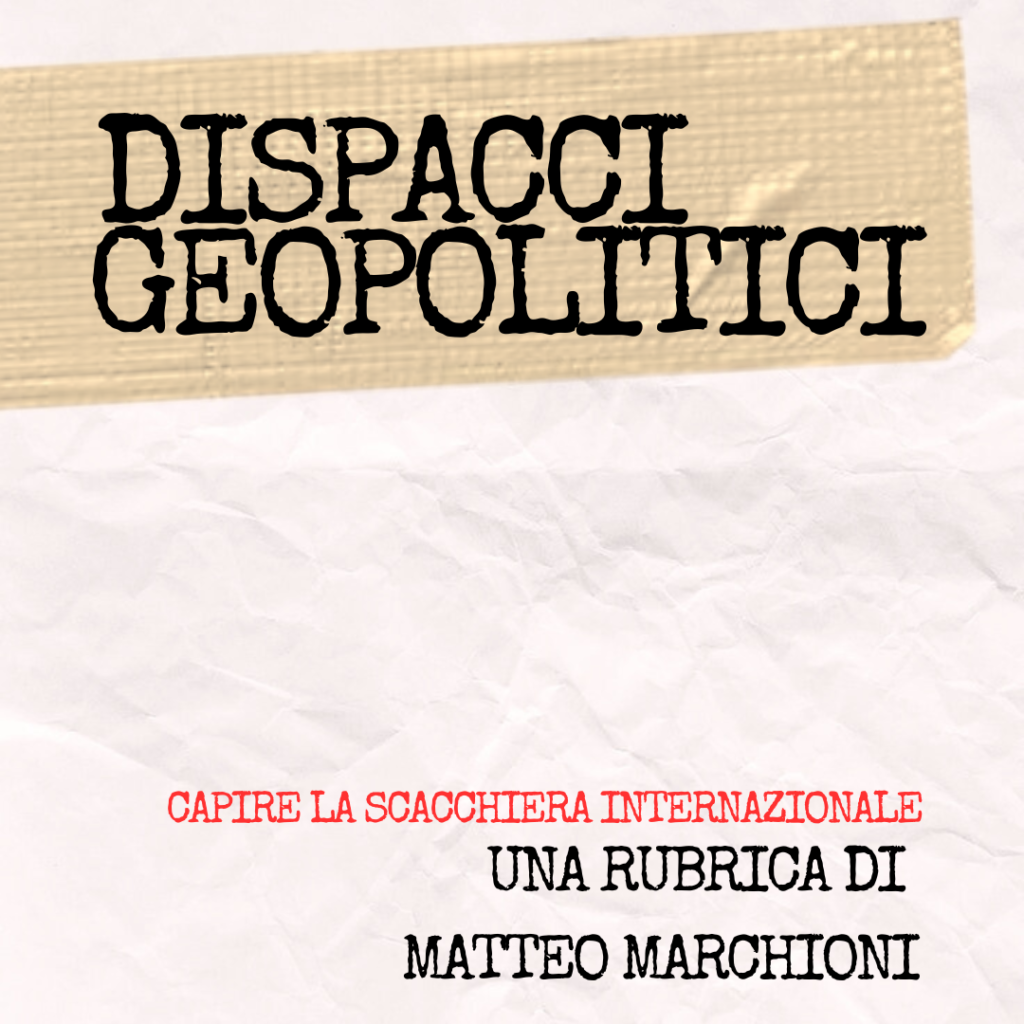
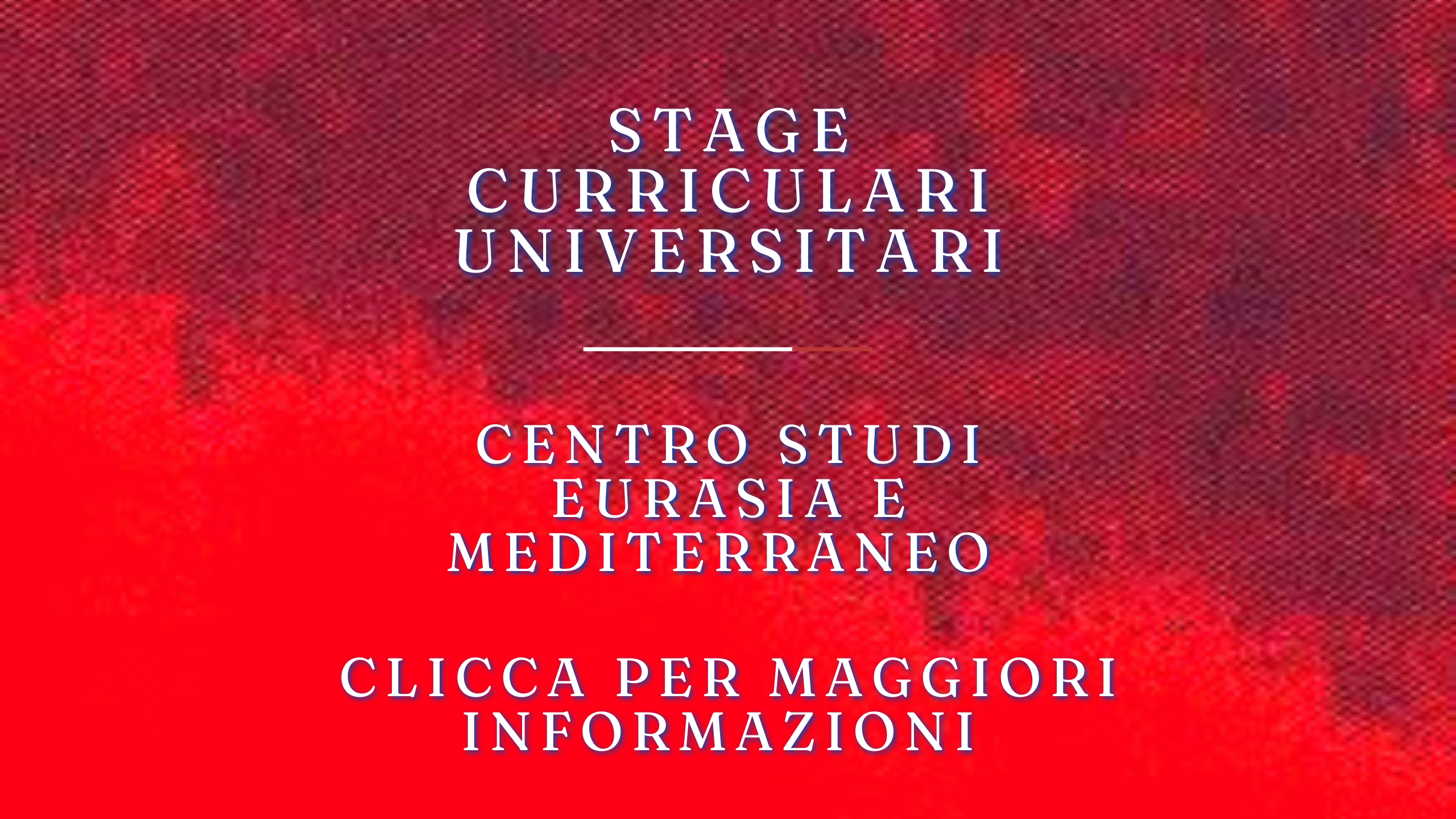

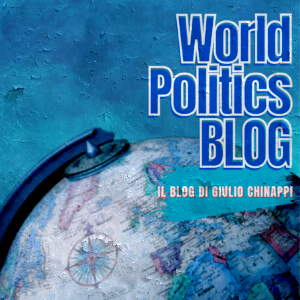
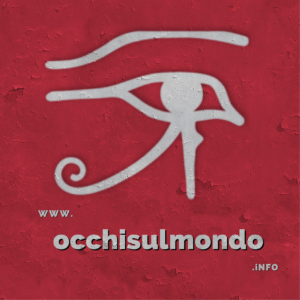









Il CeSE-M sui social