Marco Costa, analista del CeSEM, nonchè autore di numerosi articoli e libri sulla Cina e la questione del Tibet, viene citato sui siti web di diversi quotidiani nazionali, riguardo la sciagurata scelta del Comune di Milano di conferire la cittadinanza al Dalai Lama.
Nota: contrariamente a quanto sostiene il Corriere della Sera ricordiamo che l’accordo del 1951 fu firmato dallo stesso Dalai
Lama. Come afferma lo stesso Costa in ” Conoscere il Tibet”
http://www.agichina.it/sguardo-sul-tibet/notizie/tibet-crocevia-tra-passato-e-futuro
http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/dalai-lama-1.2602140
Di seguito pubblichiamo l’articolo Conoscere il Tibet di Marco Costa
CONOSCERE IL TIBET – Marco Costa
Il Tibet – regione chiamata dai cinesi Xizang – è quella regione appartenente alla Repubblica Popolare cinese a cui è stato riconosciuto lo stato di autonomia nel 1965. Molte parole, articoli, film si sono spesi a proposito (e a sproposito) del Tibet, ma spesso con una scarsa e superficiale – quando non strumentale – conoscenza della storia, della cultura e della specificità religiosa di questa regione.
Una “questione tibetana” propriamente detta esiste più che altro in Occidente, ed è promossa da diversi centri di potere che sono interessati ad attuare azioni di disturbo nei confronti della “pacifica ascesa” condotta dal governo cinese. Se la Cina, come abbiamo accennato prima, risulta essere un ineludibile partner economico-finanziario per le economie di Europa e Stati Uniti, rimane pur sempre un antagonista dal punto di vista della Nato e di coloro che rimangono ancorati ad una visione egemonica ed unilaterale dei rapporti geopolitici. Sul Tibet, davvero, sui media occidentali siamo stati bombardati per decenni da falsità imbarazzanti, strumentalizzazioni ipocrite e perfino di goffe ricostruzioni storiche. E nell’opinione pubblica, purtroppo, questo accanimento ha avuto una certa presa, in un surreale clima hollywoodiano in cui il racconto immaginifico della realtà ha finito per soppiantare la realtà stessa. Basta esaminare punto per punto gli argomenti solitamente prodotti a supporto di questa paradossale tesi della presunta indipendenza tibetana. Il Tibet era stato parte dell’Impero Cinese per circa 700 anni, dal (1270-1370) Yuan che comprende Cina, Mongolia, Tibet, dal 1368 al 1644 il Tibet era uno Stato vassallo della dinastia cinese Ming, alla fine dinastia cinese manciù, Qing (1644-1911). Il governo nazionalista del Kuomintang continuò a considerarlo come tale, e nel 1951 Mao Zedong e le sue truppe completarono il percorso rivoluzionario rientrando pacificamente nella regione. Tanto è vero nello stesso anno lo stesso Dalai Lama e le autorità locali tibetana firmarono il cosiddetto “accordo dei 17 punti”, in cui riconoscevano la sovranità cinese sul Tibet. Il Dalai Lama scapò volontariamente dal Tibet solamente nel 1959, per un motivo ben preciso: in quell’anno sarebbero entrate in vigore le prime riforme economiche del nuovo corso, che si concretizzarono in una vasta riforma agraria mirante alla ridistribuzione della terra ai contadini, intaccando così il quasi millenario sistema di servaggio attuato dai ricchi lama locali che – ben distanti dall’ascetismo che qualcuno immagina – avevano sempre retto il loro potere temporale sulla servitù della gleba. Qui si apre infatti un’altra questione; spesso il lamaismo è rappresentato dalla propaganda occidentale come un incantato mondo mistico fatto di pace, contemplazione e saggio raccoglimento ascetico. Nulla di più falso; quando il Tibet era retto dalla teocrazia lamaista, gli individui laici, ovvero i contadini, non erano padroni nemmeno dei loro figli, essendo ogni persona proprietà del singolo lama. Esistevano punizioni corporali tanto severe quanto surreali, le altre minoranze religiose venivano perseguitate – tra cui quella cristiana, basta leggere le interessanti memorie dei Frati Cappuccini presenti nel XVIII secolo e il trattamento loro riservato – non esisteva legge né proprietà che non fosse a discrezione dei lama; una teocrazia appunto, in cui ordine religioso, ordine giuridico e sistema economico erano la medesima cosa. La plebe lavorava faticosamente le impervie terre, ed i lama erigevano le loro imponenti statue del Buddha in oro massiccio. Anche qui, a onor del vero, va fatta un’ulteriore fondamentale precisazione. Tra le falsità che solitamente si ascoltano, vi è quella di aver surrettiziamente spacciato il lamaismo come il buddhismo tibetano o, ancor peggio, come il buddhismo in senso lato. Questa appropriazione indebita non può essere capita se non si conosce almeno sommariamente complessità del buddhismo, e delle sue tre principali emanazioni. Per riassumere schematicamente, l’attuale Dalai Lama rappresenta semplicemente il vertice di una scuola, i gelugpa, i quali hanno assunto la predominanza all’interno del lamaismo. A sua volta il lamaismo (al pari della tradizione zen), è una delle due correnti che compongono una delle tre vie principali del buddhismo contemporaneo, la corrente varjayana. Risulta pertanto incontrovertibile il fatto che il lamaismo costituisca solamente una confessione – peraltro assai minoritaria – all’interno dell’ampio e variegato universo filosofico-spirituale del buddhismo. Il lamaismo è quindi una minoranza della minoranza del buddhismo, e ne rappresenta più o meno il 2% dei seguaci. È noto chi ha sostenuto questa campagna di costante falsificazione mediatica. Provocatoriamente, mi verrebbe da dire che quando il Dalai Lama o qualche suo poco informato accolito occidentale parla di promozione “diritti umani” e di “libertà”, è credibile più o meno come se un nazista parlasse di promozione del multiculturalismo e delle tutela delle minoranze etniche. Peraltro questa affermazione è provocatoria fino ad un certo punto, visto che alcuni nazisti hanno ammirato il sistema lamaista quale esempio di autoritarismo teocratico, basta leggere il celebre volume “Sette anni in Tibet” dell’esploratore nazista Heinrich Harrer.
Così come bisognerebbe accennare, almeno a grandi linee, ai principali dati dello sviluppo economico e turistico di questa regione autonoma cinese negli ultimi decenni. Benché oggi il turismo in Tibet abbia raggiunto dimensioni eccezionali, si tratta ancora di un fenomeno prevalentemente nazionale in quanto il 95 % dei visitatori è cinese. L’industria si erge dunque a simbolo del rilancio economico di una delle regioni più arretrate della Cina ed è strategico in questo l’ampliamento della rete di trasporti multi-nodale di strade, aeroporti e ferrovie. Dal 2011, il governo regionale ha investito circa 1,5 milioni di Rmb per la costruzione di strade vicino a monasteri e altri luoghi di culto ed entro la fine di quest’anno il 70 percento dei 1.700 monasteri registrati dovrebbe essere reso accessibile. Prima dell’apertura della ferrovia che collega il Tibet al Qinghai (2006), gli investitori stranieri erano praticamente assenti fatta eccezione per i pochi bar e ostelli di scarsa qualità. Gli effetti sono stati immediati: 4 milioni di turisti già nel 2007, segnando un incremento del 60 percento rispetto all’anno precedente. Pechino continua quindi a puntare sul trasporto ferroviario per espandere via terra i suoi mercati e contemporaneamente stimolare le regioni occidentali relativamente più arretrate. Allo stesso tempo, però, dati i costi per la costruzione di strade e ferrovie in un’area prevalentemente montuosa, si è proceduti all’ampliamento della rete aeroportuale (Lhasa, Qamdo, Nyingchi, Ngari e Shigatse) con 310 voli settimanali operati da nove compagnie aeree verso 38 città, registrando 3,15 milioni di visitatori nel solo 2014. Così come è stato fondamentale il poderoso lavoro di recupero, restauro e riapertura dei principali siti architettonici e religiosi. L’agenzia ufficiale cinese Xinhua ha affermato che il governo ha speso 300 milioni di yuan (più di 30 milioni di euro) dal 2002 per restaurare il Potala, la cui facciata domina la città di Lhasa, e il Norbu Lingka, la residenza estiva dei Dalai Lama. Nei lavori – nel quadro dei quali Pechino ha speso anche 94,74 milioni di yuan (9,6 milioni di euro) per rimettere a posto il Monastero Sagya, che custodisce i testi classici del buddismo – sono stati impegnati più di 189mila operai.
Questo in un quadro più generale dello sviluppo economico della regione tibetana, che continua a crescere costantemente, come i dati più recenti confermano. Il Prodotto Interno Lordo della regione è aumentato vertiginosamente dai 129 milioni di yuan nel 1951 agli 80,767 bilioni di yuan nel 2013, numeri che testimoniano un incremento del 12,1% rispetto al PIL 2012 e un valore del 4,4% più alto rispetto alla media nazionale cinese. Il totale delle vendite al dettaglio dei beni di consumo ha raggiunto i 29,322 bilioni di yuan, un incremento del 15,1% rispetto all’anno precedente. L’utile netto annuale pro-capite degli agricoltori è salito a 6.578 yuan, una crescita del 15% e di 2,3 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale: il secondo tasso di crescita maggiore del paese. Il reddito annuale pro-capite disponibile della popolazione urbana è di 20.023 yuan, un incremento dell’11,1% rispetto al precedente anno e dell’1,4% più alto rispetto alla media nazionale, che vale il primato all’interno della Repubblica Popolare Cinese nonostante nel 2013 più di 28.000 persone si siano trasferite nelle città per cercare lavoro. A questo proposito nel 2013 il Governo regionale ha stanziato un fondo speciale per offrire 7.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel settore pubblico, mentre gli addetti nel settore privato sono aumentati dell’11,9% se paragonati alla percentuale dell’anno precedente. Nel 2014 sono state aumentate le pensioni mensili da 302 a 3.006 yuan, la soglia più alta della Cina, insieme all’adeguamento del reddito minimo e alle nuove forniture di cibo e indumenti per le famiglie bisognose, inoltre 2 milioni di yuan in 3 anni (2014-2016) sono stati destinati alle adozioni e al mantenimento dei bambini orfani. Ovviamente questi risultati non sarebbero stati possibili senza il supporto del Governo centrale e il contributo delle regioni più sviluppate, sussidi finanziari calcolabili in 54,8 bilioni di yuan; dal 2011 al 2015, Pechino ha previsto di completare 226 dei maggiori progetti per il miglioramento del benessere generale, la costruzione di infrastrutture, industrie e per lo sviluppo ambientale, un totale di investimenti pari a 193,1 bilioni di yuan, 71,5 dei quali erogati direttamente.
Insomma, se in Occidente la questione tibetana ha riscosso tanto successo all’interno delle dinamiche comunicative, lo ha fatto spesso a spese di una scarsa comprensione della complessità di questa regione, barattata per un marketing politico anticinese di scarso valore che ha provato a “vendere” la questione tibetana e il suo brand “free tibet” come fosse un marchio qualunque. La storia e l’analisi sociale, sembrano invece smentire questo approccio riduzionistico.
















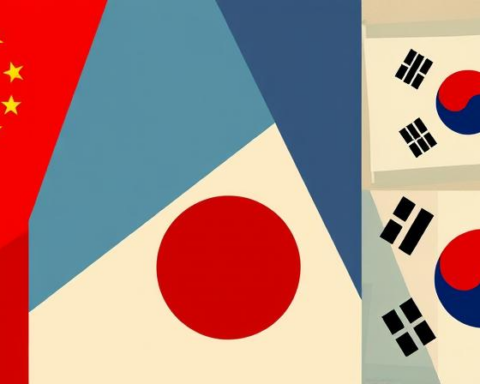



Il CeSE-M sui social